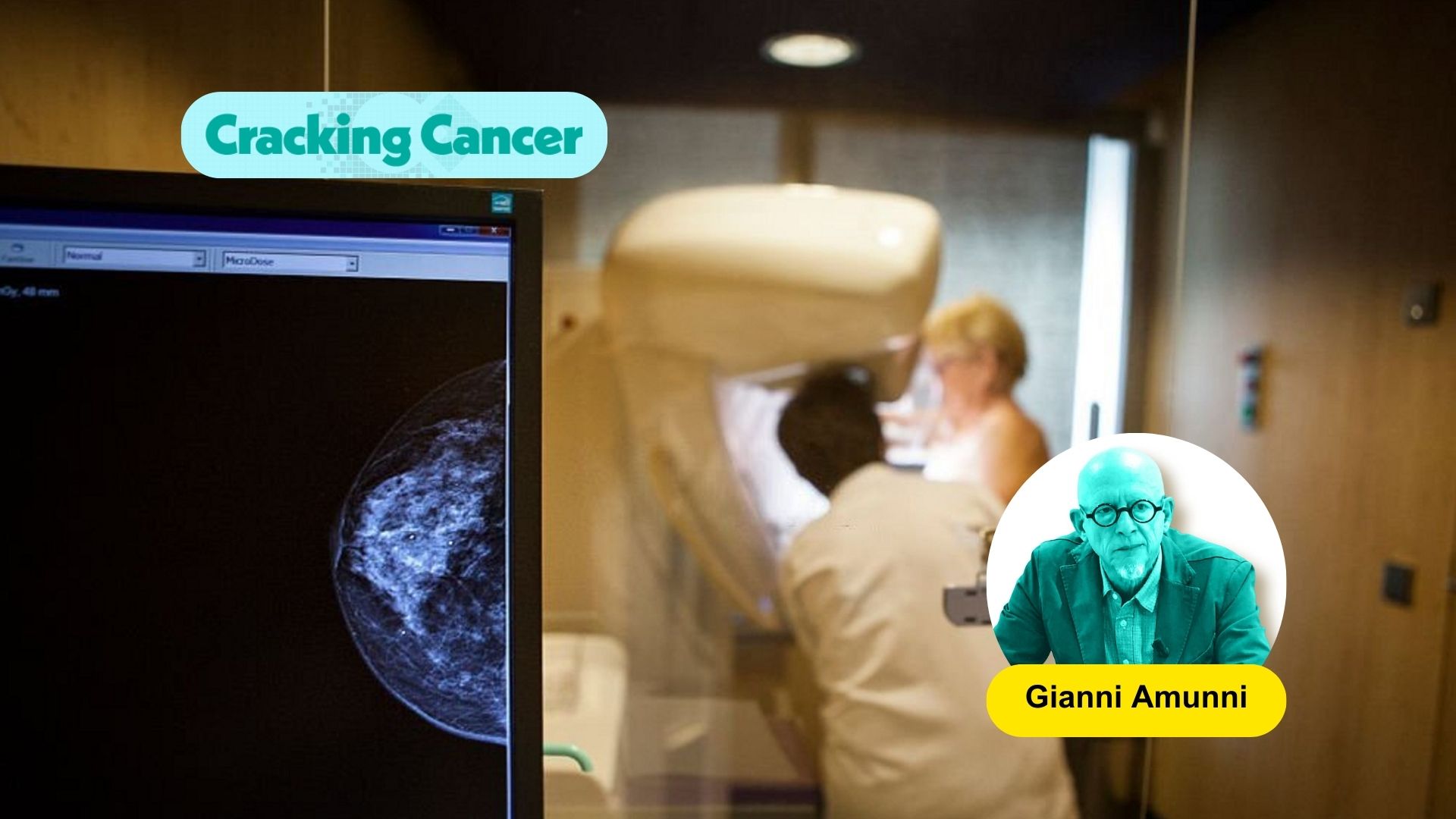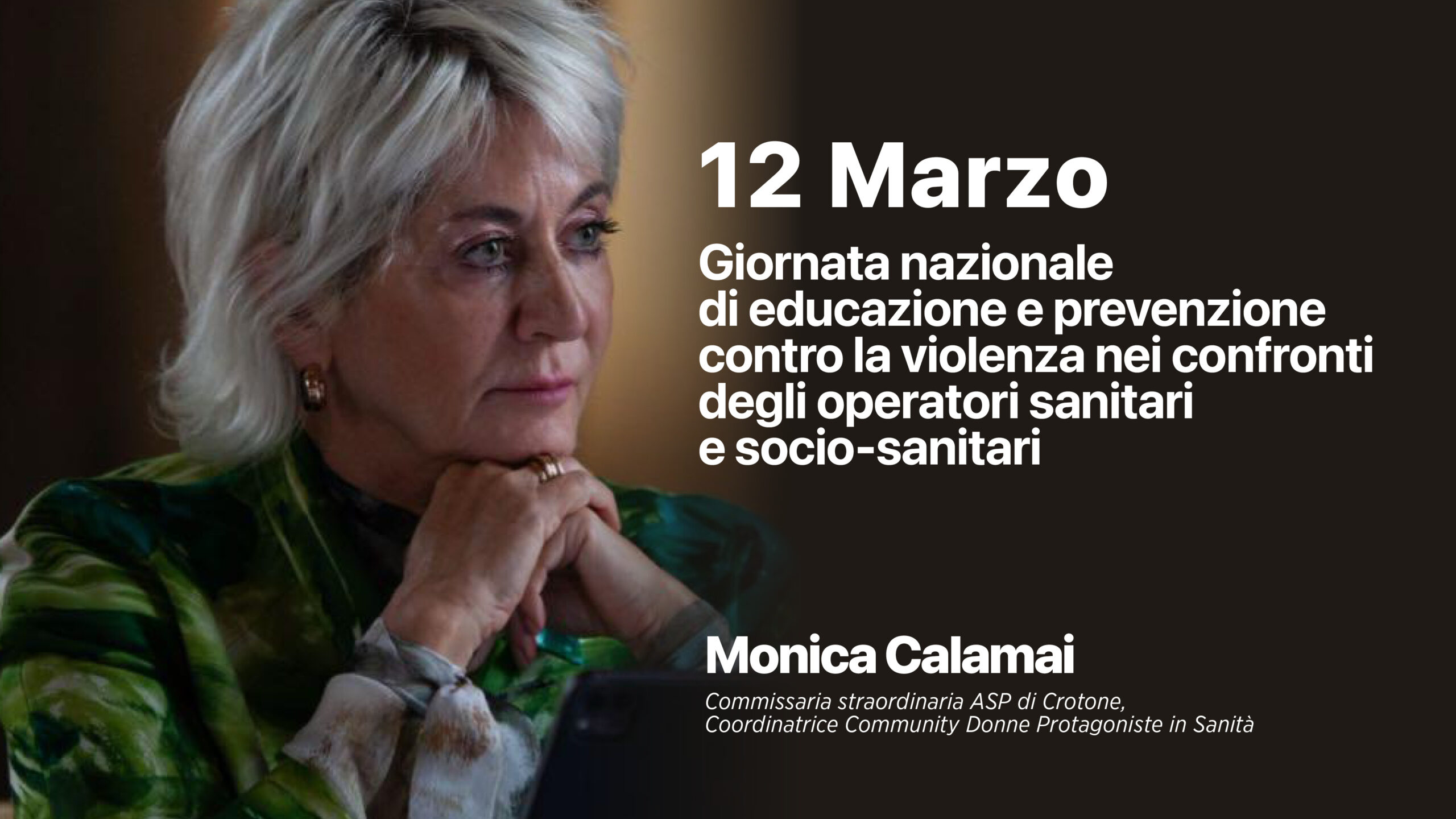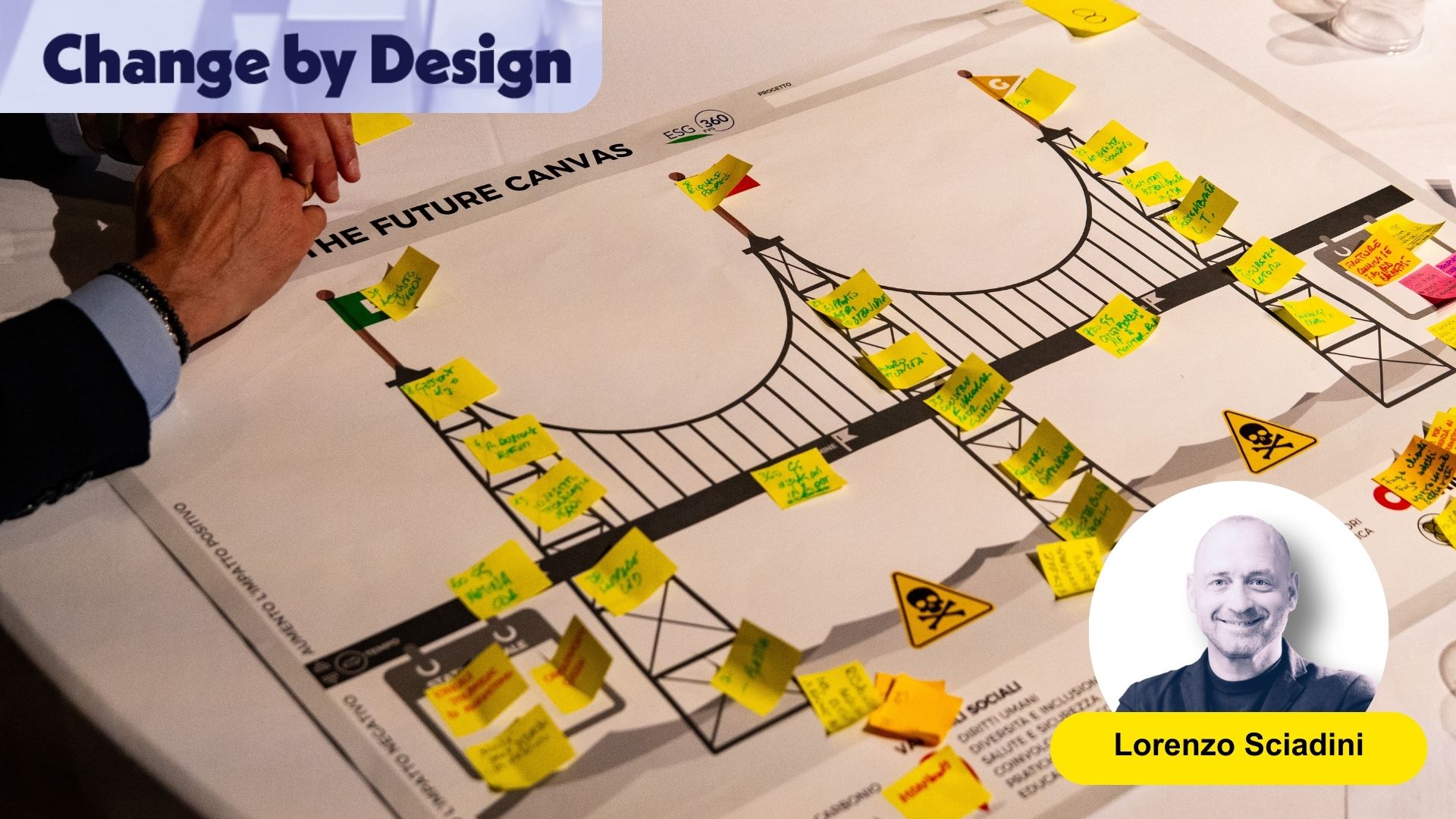Di recente un mio viaggio negli USA ha stimolato alcune riflessioni sullo stato di maturità dei sistemi sanitari nei paesi occidentali. In particolare è noto che negli USA, pure a fronte di una spesa sanitaria elevata in relazione al PIL, il sistema non offre garanzie di universalità e uniformità delle prestazioni. Inoltre il sistema legato alle assicurazioni, condizionato dal datore di lavoro e da scelte di copertura dei singoli (per esempio quanta franchigia rispetto al “rischio” di fruire di prestazioni sanitarie si è disposti a sostenere) rende il sistema estremamente frammentario e sicuramente molto distante dal sistema italiano, sostenuto dalla fiscalità generale e con garanzia di livelli essenziali di assistenza. Sui muri di San Francisco ho visto campeggiare la scritta “Health care is a right”, lo slogan proseguirebbe con un finale “not a privilege”. Negli USA il dibattito su quale assistenza sanitaria fornire ai cittadini è tutt’altro che risolto: il range va tra chi teme “voragini” nella finanza pubblica in caso di estensione di sanità gratuita ai meno abbienti (con il rischio di aumento delle tasse) e chi continua a evocare un servizio sanitario nazionale, secondo standard “europei”. I dilemmi oggi sono lasciati ai singoli stati che ampliano o restringono le coperture di welfare secondo le “sensibilità” locali, come la California ormai considerata, tra gli stati Usa, il più attrattivo per chi è in cerca di sussidi non disponibili in altri stati. Alcuni attribuiscono a questa attrattività un significativo aumento dei senza tetto in diverse città della California.
Il dibattito americano sempre aperto, a noi può sembrare surreale. Solo i più anziani ormai ricordano il sistema antecedente al 1978, anno in cui è stato varato il Servizio Sanitario Nazionale. In quel sistema di mutue si annidavano le differenze tra l’essere un operaio assistito dall’INAM e l’essere un impiegato statale assistito dall’ENPAS. Grandi poliambulatori e code per i primi, ambienti più “ovattati” e veloci per i secondi. Per non parlare delle diverse mutue per categoria professionale (commercianti, artigiani, ecc…). La sanità privata era residuale e pagata a tariffa o a retta giornaliera in caso di ricovero di un “mutuato”.
Il Servizio Sanitario Nazionale, che a breve compirà i suoi primi 50 anni, è un “fatto” per tutti noi. Anzi il concetto di diritto alle cure è così radicato da determinare un sistema di aspettative assolutamente elevate. L’evoluzione del SSN ha avuto molte svolte, da sistema universale e gratuito a sistema in cui si compartecipa alla spesa, da sistema con forte intervento della politica (chi ricorda i Comitati di Gestione degli anni ՚80?) a un sistema governato da manager, i Direttori Generali, figure introdotte con i decreti di riordino del 1992 e su cui è sempre in auge il dibattito su quali caratteristiche e competenze debbano avere, chi li debba scegliere e come, dimenticando che sui Direttori Generali pesano tali e tante responsabilità gestionali e sociali che davvero hanno pochi riscontri in altri ambiti dell’amministrazione pubblica e non solo.
Un dibattito, spesso asfittico, tra chi vede la comunità di Direttori Generali composta per alcuni da “nominati” e per altri da “supermanager” con l’ossessione per i conti, che non evidenzia un dato di realtà: questa comunità è stata quella che con i propri collaboratori e il personale ha “svangato” la peggior pandemia del secolo. Per un certo periodo durante e dopo l’emergenza l’attenzione si è concentrata sul lavoro di medici e infermieri, davvero benemeriti e bravissimi. Ma ricordo dal mio osservatorio alle Direzione del Papa Giovanni di Bergamo lo sforzo di far comprendere il lavoro corale di tutti, anche di ingegneri, tecnici, amministrativi, ausiliari, ditte esterne… per affrontare una emergenza mai vista. Oggi il paradosso è che anche i medici e gli infermieri, descritti come eroi, sono tornati ad essere i soggetti verso cui troppo spesso si scatenano le frustrazioni di persone che con veemenza, a volte perfino con violenza, esprimono le proprie “elevate aspettative”.
È urgente e non più rinviabile prendere in mano le lezioni che il covid ci ha lasciato.
Innanzitutto, è urgente mettere mano alle assunzioni. Le lodevoli iniziative per eliminare o neutralizzare il costosissimo sistema dei “gettonisti” deve liberare risorse per creare lavoro vero in un quadro per altro di percentuale del PIL dedicato alla sanità inferiore a quello di altri stati. La sanità è stata per troppo tempo e, aggiungerei, in modo “trasversale”, oggetto di programmazione miope sul personale, di spending review a più riprese. Ritengo che dopo tante operazioni di “efficientamento” e piani di rientro si sia arrivati al fondo del barile e sia tempo di trovare un nuovo slancio. Non lo chiede solo la storia sanitaria del nostro paese ma più realisticamente il dato demografico italiano, e il conseguente aumento delle condizioni di cronicità, che deve essere aggredito “per tempo”. Tornando ai necessari investimenti sul personale ricordo che una comunità che si avvale di persone strutturate, tranquille circa il proprio futuro e i percorsi di carriera, rende decuplicato il costo sostenuto, oltre ad agire grandemente sul benessere organizzativo. Magari aumentando l’attrattività verso le professioni sanitarie oggi ai minimi termini.
Il Covid lascia in eredità anche parole che oggi sono sulla bocca di tutti: sanità del territorio. Tutti ne parlano, qualcuno in un recente passato anche in chiave politica, promuovendo campagne per dimostrare che in alcune zone ce ne è di più, in alcune zone un po’ di meno. La verità è che “sanità di territorio” ha un nome e cognome: medici di famiglia. È irrisolto il tema delle regole di ingaggio, i medici di famiglia che collaborano nelle case di comunità sono quelli che già c’erano prima nelle case della salute o simili. Purtroppo il DM 77 ha mutuato, da esperienze di alcune regioni, uno standard in modo acritico. Mi chiedo per esempio che senso avrebbe costringere un medico di famiglia nelle nostre valli o zone interne del paese ad aprire un ambulatorio in una casa di comunità solo perché lo prevede uno standard con il rischio concreto di sguarnire un ambulatorio più periferico e ancor più prezioso per la popolazione. Anche qui una spasmodica attenzione all’ottemperanza a uno standard che vale da Bolzano a Lampedusa, ha rallentato i veri progetti per convincere i Medici di famiglia a dedicare una parte del proprio tempo alla “comunità”. Non ad aprire un ambulatorio, magari concesso gratuitamente, lontano chilometri dai propri assistiti.
Ma oltre a investimenti sul personale e a una riflessione tecnica e non ideologica sul ruolo dei medici di famiglia a vantaggio della comunità e dei cronici in particolare è tempo di tornare ad esercitare una funzione pubblica per eccellenza: la governance di tutti gli attori del sistema sanitario. È noto in economia che ogni soggetto persegue le proprie finalità “istituzionali”: le aziende sanitarie pubbliche sono in prima linea per assicurare i Lea, i privati no profit spesso si muovono in una logica di sussidiarietà per integrare il sistema pubblico. Poi c’è il privato profit che tra le sue finalità istituzionali ha ovviamente anche quelle della redditività della propria attività. Ecco è in questo passaggio che il sistema delle regole pubbliche deve essere rigoroso per esigere la massima aderenza alle finalità pubbliche del SSN. Mi piacerebbe proporre una riflessione: quale è il grado di elasticità concedibile a soggetti privati che agiscono in quanto “concessionari” di un servizio pubblico come quello sanitario? Vale ancora il principio per cui il privato integra le attività pubbliche o è in corso una sostituzione anche grazie alla crescita esponenziale che la sanità privata ha avuto negli ultimi decenni grazie alle regole dell’accreditamento previste nei decreti di riordino del 1992?
Sono domande importanti, da non sottovalutare. Anche in Italia una sanità sempre più privata si muove, proponendosi ai cittadini con un doppio canale, uno pagato dai contribuenti e uno parallelo dalle tasche dei cittadini. Sono domande importanti che richiedono decisori e manager preparati, competenti e assolutamente indipendenti.
Investire in sanità non è solo un tema di “cassa”. È realizzare scelte consapevoli e di ampio respiro strategico per il futuro.